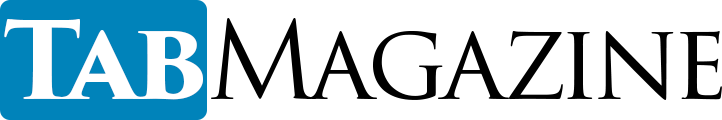Stiamo entrando nell’era del “quiet quitting”?
31 Luglio 2023
Le generazioni più giovani provano sempre più insofferenza nei confronti della dedizione quasi totale al lavoro. E adottano un nuovo approccio. La psicologa Alisia Galli ci spiega i motivi di questo cambiamento di prospettiva

Da una parte, la digitalizzazione crescente e il lavoro agile, che hanno cambiato (soprattutto per i giovani) il mix tra vita professionale e personale. Dall’altra, salari sempre più bassi, precarizzazione del lavoro, disoccupazione giovanile alle stelle, meno speranze di far carriera e stress dilagante. Sono queste alcune delle ragioni che spingono le generazioni più in erba a cambiare prospettiva nei confronti dell’attività professionale. E a sostituire alla dedizione quasi totale al lavoro una nuova mentalità dominante, il quite quitting. Cioè: fare ciò che il contratto di assunzione recita e nulla più, o quasi.
Nuovo atteggiamento
Il brusco passaggio di prospettiva fra la mentalità workaholic degli anni scorsi e quella attuale è stato evidenziato anche da Alisia Galli, psicologa clinica e leader pillar mentale di Fitprime, società di servizi specializzata in welfare aziendale.
“Dopo anni in cui ci siamo dimostrati sempre impegnati, credendo che questo ci rendesse interessanti agli occhi degli altri, oggi, soprattutto le nuove generazioni di lavoratori, a questo gioco non ci stanno più”, sottolinea infatti Alisia Galli. “E molti hanno deciso di cambiare il proprio atteggiamento”.
Il fenomeno non è così recente come si potrebbe pensare, se è vero che, secondo un report dello scorso anno di Gallup, “solo il 14% dei dipendenti in Europa è davvero coinvolto sul lavoro. Una situazione che spesso dipende dal rapporto con il proprio capo, che dovrebbe essere empatico e complice. Sempre secondo lo stesso sondaggio sta venendo meno la predisposizione a dedicarsi completamente all’azienda, rimettendo al centro se stessi, le proprie relazioni e benessere. Un fenomeno che è stato registrato inizialmente da Tik Tok e poi dagli altri social, e che viene definito quiet quitting (abbandono silenzioso)“.
A prima vista, afferma la psicologa, si potrebbe pensare che “abbracciare questo comportamento significhi fare il minimo indispensabile, non impegnarsi per nulla. Insomma, essere nulla più che lavativi. Questa interpretazione del quiet quitting però è impropria e in realtà il fenomeno racchiude ben altri valori”.
Carta canta
Altri valori. In che senso? “Fare quiet quitting“, risponde Alisia Galli, “in realtà vuole dire semplicemente lavorare nei tempi e nei modi indicati dal proprio contratto, senza fare straordinari o assumersi responsabilità ulteriori. Si tratta di persone che decidono di adempiere alle loro mansioni lavorative, ma di non aderire alla cultura del “lavoro è vita” per guidare la loro carriera e distinguersi agli occhi dei superiori. Si attengono ai propri compiti e quando tornano a casa lasciano il lavoro alle spalle e si concentrano su attività di altri tipo: famiglia, amici, hobby e via dicendo”.
Generazione Z
Come già accennato, a fare sua questa prospettiva “è soprattutto la Generazione Z“, e per farlo “stabilisce limiti che possono essere: non usare il cellulare aziendale fuori dall’orario d’ufficio, fare pause intenzionali durante il lavoro, prendere un impegno in pausa pranzo per sciogliere il senso del dovere che ci farebbe finire una riunione mentre mangiamo. “Se i limiti non li mette l’azienda, allora li mettiamo noi”: questo è il pensiero di chi sceglie il quiet quitting. Che significa, in altri termini, fare scudo contro il lavoro che invade la vita privata, definirne i confini e riconsiderarne il ruolo”.
Disillusione e stress
Ma perché questo cambiamento? “Da un lato c’è certamente una disillusione nei confronti del mondo professionale e della possibilità di fare carriera, derivata dalle crisi che si sono susseguite dal 2008 a oggi. Crisi che hanno reso il panorama del lavoro molto diverso e decisamente meno premiante rispetto al periodo del boom economico degli anni Ottanta e Novanta. I nuovi lavoratori pensano che convenga di più riprendere in mano la propria quotidianità e trovare soddisfazione al di fuori del contesto professionale”.
Ma, prosegue la psicologa, “il quiet quitting è anche un segnale di chi decide di mollare la presa perché si trova in una situazione di stress sul lavoro e sta avvicinandosi pericolosamente al burnout, fenomeno ormai dilagante. Con questo termine nato in ambito sportivo e poi trasportato in quello psicologico si indica uno stato di stress cronico lavoro-correlato, una vera e propria sindrome ormai riconosciuta anche dall’Oms. Si pensi che secondo un’indagine dell’Eu-Osha, più di quattro lavoratori su dieci (44%) affermano che lo stress da lavoro è aumentato a seguito della pandemia, e quasi la metà (46%) ha dichiarato di essere esposta a una forte pressione del tempo o a un sovraccarico di lavoro”.
E il datore di lavoro?
Questa situazione, secondo Alisia Galli, molto probabilmente non è per nulla passeggera. E potrebbe segnare la fine per l’epoca della dedizione quasi totale alla vita professionale. Tuttavia, prosegue, “questo non è necessariamente un male per il datore di lavoro. Ascoltando da vicino le esigenze dei suoi dipendenti, potrà infatti avere con sé persone meno sull’orlo della crisi. Più soddisfatte e quindi creative, performanti e disposte a restare. Il concetto di quiet quitting infatti promuove un approccio attivo e consapevole per affrontare il sovraccarico e lo stress e porta la persona a dare importanza al proprio benessere mentale e fisico. La chiave è, come accennato, l’ascolto. Per esempio, il quiet quitting potrebbe anche essere un segnale che un dipendente non è felice nella sua posizione. E non è detto che in questa situazione non si possa trovare una soluzione che soddisfi sia le necessità aziendali sia quelle del dipendente. Se l’abbandono silenzioso è invece il sintomo di una vicinanza al burnout, è chiaro che l’azienda deve intervenire per garantire la salute mentale del proprio lavoratore. Per convivere con questo fenomeno è chiaro come sia importante per i datori di lavoro non osteggiarlo ma comprenderlo e gestirlo”.
Giocare per lavorare meglio
Come fare? “Per riuscire in questa impresa non semplice è importante avere gli strumenti adatti, sia culturali, sia pratici. In primis le aziende dovrebbero sviluppare una cultura aziendale in cui si promuova il benessere, l’importanza di prendersi del tempo per sé e di praticare l’autocura. Al contesto culturale andrebbero affiancate azioni pratiche che spingano i dipendenti a ristabilire il bilanciamento tra vita privata e lavoro: non è un caso se già oggi sempre più aziende stanno inserendo il wellbeing delle persone all’interno della propria strategia di responsabilità sociale d’impresa. Tra le azioni possibili, ci sono strumenti che aiutano le persone a prendere consapevolezza del proprio livello di stress – come per esempio gli assessment game. Si tratta di videogiochi basati su parametri psicometrici che restituiscono un’idea dello stato di disagio e anche di eventuale burnout della persona (un esempio italiano è WorkDown, lanciato dalla startup Game2Value). O ancora, strumenti che supportano i lavoratori nel loro benessere psicofisico attraverso agevolazioni per lo sport, la nutrizione e la salute psicologica”.